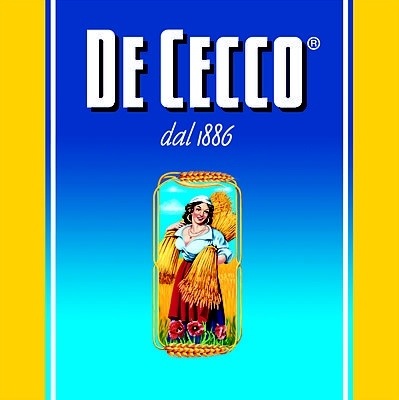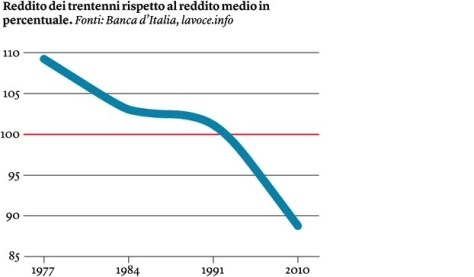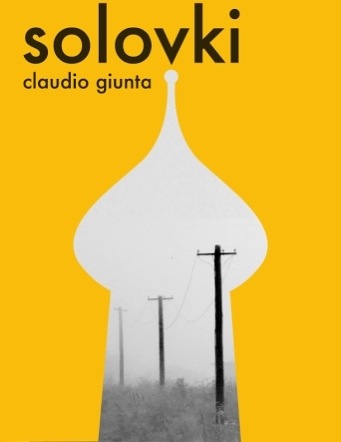di Michele De Sanctis
Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che, dopo aver investito ed ucciso un pedone, che a sua volta aveva attraversato la strada imprudentemente, è finito sotto processo con l’accusa di omicidio colposo per non aver osservato le comuni regole di prudenza.
È quanto afferma la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 14776, depositata in data 31 marzo 2014, con cui ha rigettato il ricorso dell’imputato, che chiedeva che fosse riconosciuta e addebitata alla vittima la totale responsabilità nel sinistro (ottenendo, quindi, l’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo) e non il semplice concorso di colpa (nella fattispecie, riconosciuto dalla Corte d’Appello di Roma nella misura del 40% e non più sindacabile dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto valutazione di merito – non valutabile nel giudizio di legittimità).
La vittima – si legge in sentenza – dopo essere scesa dall’autobus – aveva attraversato la strada, in un punto privo di passaggi pedonali, velocemente e senza guardare.
L’autobus da cui era sceso il pedone si era fermato, peraltro, irregolarmente all’esterno dell’area riservata alla sua sosta, perché occupata da un’autovettura.
L’auto investitrice secondo quanto accertato nel corso del giudizio di merito aveva tenuto una velocità quanto meno pari a 70-75 Km/h.
I Giudici di Piazza Cavour, riprendendo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, affermano che l’articolo 141 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), rubricato “Velocità” e i principi generali della circolazione stradale impongono sempre al conducente l’obbligo non solo di regolare la velocità del veicolo e la propia condotta, in modo che la stessa non costituisca pericolo per per la sicurezza di persone e cose, ma anche di prevedere, a seconda delle circostanze, dei luoghi e delle condizioni, i prevedibili comportamenti irregolari e finanche incoscienti degli altri utenti della strada che possano determinare situazioni di pericolo e tenere, pertanto, una condotta atta a prevenire sinistri o altri eventi antigiuridici, quale, nel caso di specie, l’omicidio di un pedone.
Non solo, la Suprema Corte ha, altresì, specificato che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro può considerarsi completamente esonerato da responsabilità solo in caso di sua osservanza di norme precauzionali scritte, assolutamente complete ed esaustive di tutti i possibili comportamenti prudenziali esigibili in relazione a determinate situazioni di pericolosità.
Tuttavia – per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione – l’osservanza di tutte le norme prudenziali “scritte” non esclude che possa, comunque, residuare una responsabilità generica derivante da quelle non scritte. In questi casi, infatti, l’adempimento delle norme scritte non esaurisce i doveri degli utenti della strada.
Tra le regole cautelari non scritte, relative alla circolazione stradale, rientra in primis il dovere generale del ‘neminem laedere’, principio di diritto romano, traslato nei successivi ordinamenti occidentali, che, facendo riferimento alla civile e pacifica convivenza, è il fondamento giuridico della responsabilità aquiliana, secondo cui siamo tutti tenuti al dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica.
Perciò, il conducente di un veicolo può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di aver procurato un danno ad un altro soggetto.
In tali casi, per escludere del tutto la responsabilità del conducente del veicolo investitore e porre esclusivamente a carico del pedone la responsabilità per i danni o la morte allo stesso derivati, è necessario che il primo si sia trovato nell’impossibilità di prevenire e/o evitare l’investimento stesso, per fatti estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, da qualsiasi fonte derivante.
Questo perché, nel caso in esame, le condizioni della strada al momento dell’incidente avrebbero dovuto imporre l’adozione di una condotta di guida particolarmente prudente e l’automobilista avrebbe dovuto, quindi, rallentare la propria marcia fino quasi a fermare il mezzo su cui viaggiava, nella prevedibile ipotesi che “pur in assenza di apposito attraversamento pedonale, qualche passeggero potesse portarsi davanti al veicolo del trasporto pubblico dal quale era appena sceso per attraversare la carreggiata”.
È vero che nel caso di specie, non sussisteva in quel tratto di strada un limite di velocità inferiore a quella tenuta dall’automobilista, che, dunque, non si trovava nell’ipotesi sanzionata dal 141 co. 2 CdS, ma è, altresì, vero che la situazione dei luoghi come quella descritta (presenza di un autobus in fermata), doveva imporre una diligenza superiore rispetto a quella della mera osservanza del limite di velocità appunto in virtù dell’esistenza di un pericolo concreto di attraversamento da parte delle persone che scendevano dal mezzo pubblico.
Non può sostenersi argomenta, infatti, la Suprema Corte che “l’imputato non potesse prevedere che da un autobus di linea fosse disceso un passeggero che, passando dietro l’autobus, ripartito da pochi istanti, attraversasse la strada quando egli si trovava a breve distanza”.
È proprio vero quel che comunemente si dice: al volante la prudenza non è mai troppa.
BlogNomos
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK
Twitter @BlogNomos