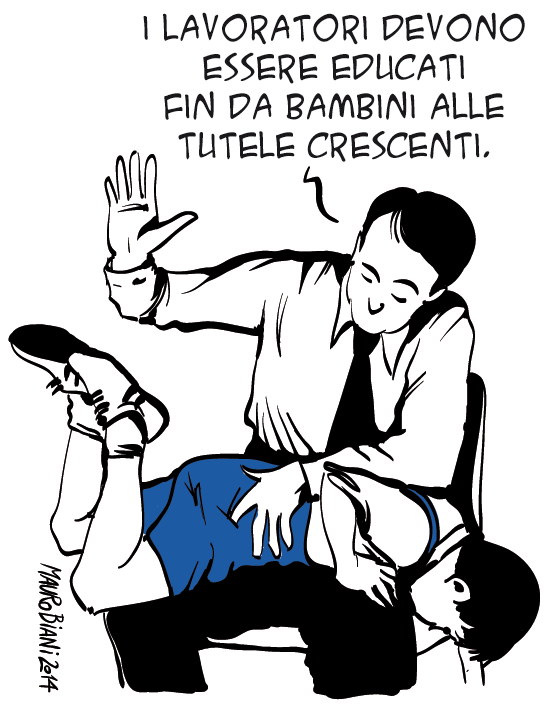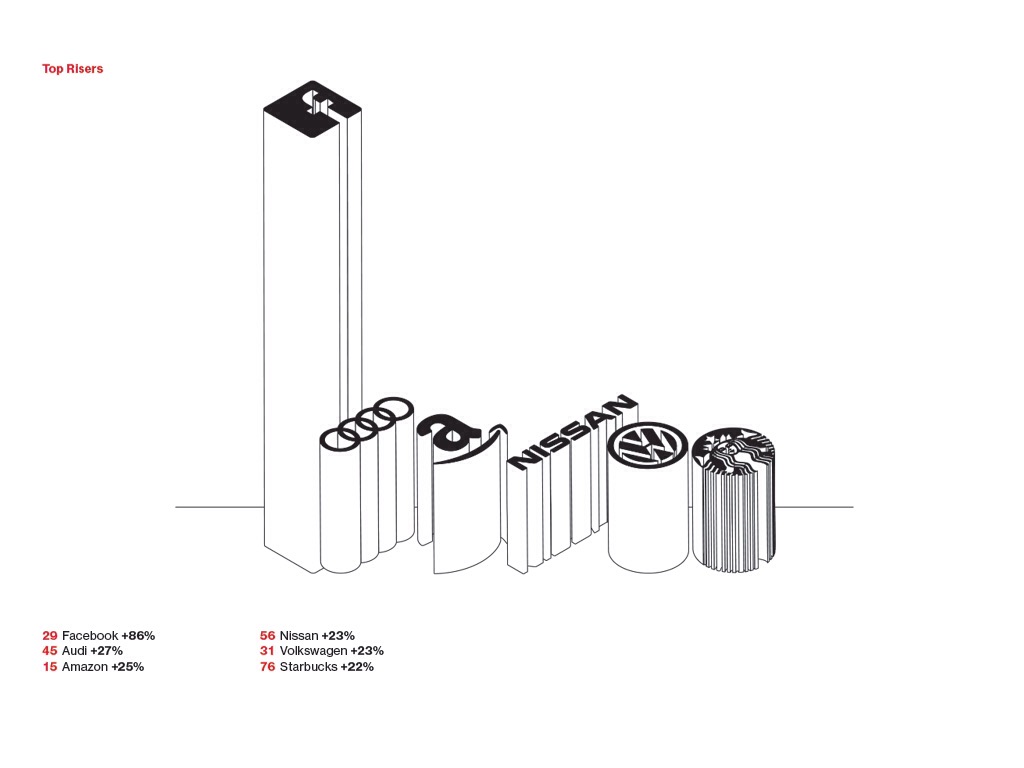di Germano De Sanctis
Premessa.
Come è noto, il sistema economico mondiale sta attraversando una delle sue fasi più difficili, a causa della pandemia di Covid-19, la cui capacità e gravità di diffusione ricordano drammaticamente l’influenza spagnola del 1918.
In breve tempo, questa emergenza sanitaria ha colpito duramente, a livello globale, il sistema economico e finanziario, generando una crisi di proporzioni tali da rendere ineludibile un intervento a sostegno delle attività produttive da parte dei singoli Stati.
Nell’attesa di un vaccino, gli Stati più industrializzati hanno già cercato di stimolare le loro economie interne:
-
emanando i primi provvedimenti a sostegno delle attività produttive;
-
adottando una serie di misure volte al rallentamento della diffusione del contagio, dedicando una particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione;
-
incentivando la sperimentazione di nuove terapie.

La necessità di un nuovo approccio metodologico.
Tuttavia, tali interventi si connotano tutti per la medesima criticità, in quanto necessita un approccio metodologico molto diverso rispetto a quello osservato finora, dovendo mutare radicalmente il ruolo che lo Stato ha svolto nel’economia globalizzata negli ultimi decenni.
Infatti, sin dagli anni Ottanta del secolo scorso, lo Stato si è progressivamente collocato in una posizione defilata nella gestione delle dinamiche di sviluppo economico, lasciando alle grandi realtà dell’imprenditoria privata il ruolo di individuare i processi economici capaci di creare ricchezza. In pratica, gli Stati occidentali sono intervenuti soltanto in presenza di problemi che richiedevano un intervento pubblico per la loro risoluzione.
Pertanto, quando è esplosa l’emergenza sanitaria in atto, si è riscontrato che non tutti i Governi hanno avuto la capacità di gestire la crisi economica in modo adeguato e tempestivo.
Tale difficoltà è stata anche accentuata dal fatto che l’ormai radicato ruolo predominante che la grande imprenditoria privata svolge nella vita pubblica ha comportato una generale perdita di fiducia da parte dei cittadini verso le reali capacità dello Stato. In particolare, tale sfiducia si è tradotta nella realizzazione di diversi partenariati pubblico-privato, che non stanno riuscendo, in questa fase, a gestire le tutele degli interessi pubblici sottesi, con l’efficienza e l’economicità tipica del privato (a differenza di quello che ci si attenderebbe).
Ne consegue che è necessario cominciare a ragionare su come sia possibile fare capitalismo secondo diverse modalità, capaci di farci superare questa crisi, con il minor numero possibile di danni economici e sociali.
Molto banalmente, bisogna ripensare il ruolo degli Stati nell’ambito di una economia che è e rimarrà capitalistica. Credo che questo ruolo debba esplicarsi mediante specifiche azioni che, anziché limitarsi a correggere gli effetti del fallimento del mercato globale così come lo abbiamo finora conosciuto, favoriscano le condizioni per la creazione di una nuova economia globale (e globalizzata), sostenibile, inclusiva e circolare.
Per ottenere risultati concreti, penso che siano necessarie subito le seguenti azioni:
-
la comunità internazionale dovrebbe creare nuove istituzioni volte alla prevenzione di crisi come quella in atto, o che, comunque, abbiano i poteri per gestirle efficacemente una volta che esse sopravvengano;
-
i Governi degli Stati più industrializzati dovrebbero dirigere e sostenere con maggiore forza le attività di ricerca e sviluppo:
-
-
dedicando una particolare attenzione alla salute pubblica;
-
promuovendo virtuose sinergie in tema di ricerca, innovazione e trasferimento dei risultati ottenuti nell’ambito delle Scienze della Vita;
-
i Governi degli Stati più industrializzati dovrebbero intervenire sui propri partenariati pubblico-privato, al fine di assicurare che i prori cittadini godano di un effettivo beneficio dalla scelta di perseguire e tutelare interessi pubblici e/o collettivi attraverso il ricorso agli strumenti privatistici;
-
i singoli Governi degli Stati più industrializzati dovrebbero fare tesoro di quanto appreso nel fronteggiare la crisi finanziaria mondiale del 2008, non pensando a mere operazioni di salvataggio delle grandi imprese in crisi che si concretizzano in semplici elargizioni di denaro pubblico. Infatti, l’aiuto pubblico deve essere accompagnato dal riscontro della sussistenza delle condizioni che garantiscano che siffatti salvataggi producano effetti resilienti sul sistema produttivo. In altri termini, i settori destinatari di aiuti pubblici dovrebbero essere coinvolti in virtuosi percorsi di trasformazione, capaci di riconvertire le attività produttive oggetto di salvataggio in realtà imprenditoriali:
-
-
concrete e protagoniste di una nuova economia globale, dove l’incidenza tecnologica degli output della loro produzione presenta un valore aggiunto così elevato da rendere ininfluente l’incidenza del costo elevato della manodopera tipico delle economie più evolute;
-
capaci di ridurre le emissioni di anidride carbonica, generando virtuosi esempi di economia circolare;
-
munite della forza economica ed organizzativa necessaria per investire sulla riqualificazione del capitale umano occupato, rendendolo capace di adattarsi all’utilizzo delle nuove tecnologie produttive.
Il sostegno alla liquidità delle imprese.
Mentre si ragiona sugli scenari erconomici futuri, una nuova economia globale non può nascere se, durante questa fase più acuta della crisi, non si preservano le aziende in sofferenza. Infatti, molte imprese hanno già subito una importante perdita di reddito, con conseguente ridimensionamento della forza lavoro assunta.
In altri termini, siamo di fronte ad una inevitabile e profonda recessione dell’intera economia mondiale ed è necessario sostenere rapidamente ed energicamente il sistema economico prima che questa recessione si tramuti in depressione. Appare ovvio che siffatta risposta energica necessiti di un significativo aumento del debito pubblico.
In altri termini, in questa fase, i bilanci pubblici devono:
-
assorbire la perdita di reddito subito dal settore privato;
-
cancellare il debito privato;
-
sostenere il debito necessario per colmare il divario tra i livelli di richezza precedenti e quelli attuali.
Anche se quest’ultima affermazione può sembrare incauta, bisogna accettare l’idea che, in futuro, i livelli elevati di debito pubblico dei Paesi più industrializzati sarà una costante dell’economia globale nel medio e lungo periodo. Ne consegue che ogni singolo Stato, così come avviene normalmente in presenza di un emergenza nazionale, dovrà impiegare proprio bilancio per proteggere i cittadini, attuando misure che, in verità, non ha nemmeno l’obbligo di attuare.
Tuttavia, l’intervento pubblico non deve limitarsi solo a garantire un reddito minimo a favore di coloro che hanno perso il posto di lavoro, ma deve anche prevenire la perdita dei posti di lavoro. In caso contrario, al termine di questa crisi, riscontreremo livelli occupazionali sensibilmente inferiori, unitamente ad una permanentemente indebolita capacità di produzione.
Quindi, pur ribadendo l’importanza del ricorso alla cassa integrazione, agli incentivi occupazionali ed al rinvio delle tasse, la protezione della capacità produttiva necessita di un immediato e robusto sostegno di liquidità.
Nello specifico, tale sostegno di liquidità deve, inizialmente, coprire le spese operative sostenute durante la fase acuta della crisi dalle (piccole, medie e grandi) imprese e dai lavoratori autonomi ed, in un secondo momento, sostenere anche i costi di produzione necessari per la riapertura delle attività produttive.
Una simile operazione di sostegno alla liquidità comporta il necessario coinvolgimento dei sistemi finanziari dei singoli Stati, evitando ogni complicazione burocratica. Infatti, il sistema bancario (ma anche quello postale) può sostenere l’economia, creando denaro in poco tempo, garantendo gli scoperti ed accendendo linee di credito.
In particolare, il sistema bancario, supportato dalla garanzia pubblica, deve garantire prestiti a costo zero alle imprese disposte a salvaguardare i posti di lavoro dei propri dipendenti. In altri termini, le banche dovrebbero diventare uno strumento delle politiche pubbliche di sostegno alla liquidità. Infatti, gli Stati dovrebbero fornire la loro garanzia sugli ulteriori scoperti o sui prestiti. Per di più, il costo di siffatte garanzie non dovrebbe essere riparametrato sul rischio di credito dell’impresa che le riceve, ma dovrebbe essere a parametro zero, indipendentemente dal costo del finanziamento del Governo che le ha emesse.
Ciò detto, bisogna tenere, però, conto che le imprese non accederanno a forme di credito agevolato, solo perché la liquidità verrà erogata a costi bassi. Infatti, esiste una platea di imprese, che, seppur potendo accedere alla liquidità agevolata, non lo faranno, in quanto l’aumento di debito che andrebbero ad accumulare rischierebbe di compromettere la loro futura capacità di investimento.
Pertanto, se si vorranno proteggere i posti di lavoro e la capacità di investimento delle imprese, gli Stati dovranno compensare i mutuatari per le loro spese, con la conseguenza che i singoli Governi dovranno assorbire gran parte della perdita di reddito determinata dalla chiusura delle attività.
Tutto questo comporterà un aumento dei livelli di debito pubblico, ma si tratterà di un sacrificio necessario, in quanto, lo scenario alternativo prevede soltanto la distruzione permanente della capacità produttiva e della conseguente della base fiscale, con evidenti ricadute nefaste sul credito pubblico. Comunque, ad onor del vero, alla luce degli attuali e pronosticati livelli dei tassi di interesse, un siffatto aumento del debito pubblico non dovrebbe minimamente aumentare i suoi costi di servizio.
Viene da chiedersi se il sistema macroeconomico europeo sia in grado di supportare una simile iniziativa straordinaria. Orbene, l’Europa gode di una strutturazione finanziaria altamente differenziata e capace di convogliare i fondi necessari verso qualsiasi settore economico che risultasse esserne bisognoso.
Inoltre, non dobbiamo dimenticare che tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea si connotano per la presenza di un forte settore pubblico, capace di porre in essere una coordinata e rapida risposta politica.
Si evidenzia che una risposta veloce in questo momento storico assume un valore strategico ed essenziale. L’esperienza maturata dopo la crisi del 1929 ci ha dimostrato che un’eventuale esitazione può comportare conseguenze negative irreversibili.
Chiaramente, una simile strategia richiede necessariamente un radicale cambiamento di mentalità, stante l’eccezionalità della situazione. Infatti, bisognerà tenere conto che, a differenza di altre crisi economiche del recente passato, si è in presenza di crisi non ciclica e di cui non ha colpa nessuno degli attori economici che sono in sofferenza.

Gli strumenti finora posti in essere dall’Unione Europea.
Nell’ambito del dibattito pubblico svoltosi in questi primi mesi di emergenza sanitaria, l’Unione Europea è sembrata assente, od incapace di assumere una strategia comune sulle politiche economiche.
Finora, la Commissione Europea ha solo stabilito alcuni principi per permettere ai singoli Stati Membri di sostenere le proprie imprese, anche se, a tutt’oggi, non vi è un unico piano europeo capace di fornire maggiori garanzie e si rischia di assistere ad una eterogenea ondata di aiuti di stato, capace solo di creare effetti distorsivi sul mercato comune.
Come abbiamo visto poc’anzi, uno dei pochi punti fermi del dibattito macroeconomico in corso consiste nel fatto che, di fronte ad un mercato “evaporato” in pochi giorni, risulti necessario un intervento statale a sostegno delle imprese, senza il quale quest’ultime sarebbero prive della liquidità necessaria per onorare le proprie obbligazioni, con la conseguenza che sarebbero costrette a chiudere od a ridimensionare le proprie attività e la propria forza lavoro.
Al fine di scongiurare che gli aiuti forniti da uno Stato Membro alle proprie imprese possano distorcere la concorrenza, il Trattato della UE ha dotato la Commissione Europea di poteri di controllo, in virtù dei quali essa ha adottato un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Tale documento persegue l’obiettivo di unificare i criteri degli aiuti di stato, finalizzati a garantire:
-
la salvaguardia della liquidità delle imprese;
-
l’accesso al finanziamento da parte delle imprese in difficoltà;
-
a mantenere intatti i livelli occupazionali, nonostante la contrazione della produzione.
Nello specifico, il predetto“Quadro temporaneo” ha previsto una serie di principi, volti ad assicurare:
-
l’efficacia degli aiuti attraverso l’individuazione soggettiva dei beneficiari. Infatti, non possano accedere alle misure le imprese che erano già in sofferenza alla data del 31 dicembre 2019 e che, di conseguenza, non possono imputare le loro difficoltà alla diffusione della pandemia da Covid-19 ed alle conseguenti misure di contenimento;
-
la natura incentivante degli aiuti erogati;
-
la limitazione degli aiuti medesimi, prevedendo che:
-
-
le garanzie statali ai prestiti al di sopra di € 800.000 non possano superare l’ammontare del 90%;
-
il capitale del prestito non può superare il 25% del fatturato annuale o del doppio della massa salariale annuale;
-
i sussidi ai lavoratori non possono superare l’80% per cento del loro stipendio mensile lordo;
-
il carattere temporaneo del predetto regime di aiuti.
Si tratta di una prima importante, ma non esaustiva apertura. Infatti, necessita un immediato coordinamento europeo delle politiche di sostegno, attraverso uno specifico programma comunitario.
Invece, anziché consumare risorse finanziare in eterogenei regimi di aiuti di stato, pagati con fondi nazionali e aventi beneficiari nazionali, sarebbe auspicabile la realizzazione di un programma europeo, finanziato a livello interamente comunitario e chiamato a svolgere un ruolo fondamentale per affrontare i cambiamenti strutturali.
Si è consapevoli che attualmente esistono difficoltà difficoltà politiche e legali per aumentare il bilancio dell’Unione Europea o per permettere alla Commissione Europea di finanziarsi direttamente sui mercati, ma l’eccezionalità della situazione impone l’adozione di iniziative non convenzionali.
Inoltre, un simile progetto potrebbe avere più chance di successo, rispetto al tentativo di finanziare programmi nazionali con i cosiddetti Eurobond.
Inoltre, un programma europeo gestito direttamente dalla Commissione Europea stroncherebbe all’origine le accuse di alcuni Stati Membri verso altri Stati Membri, tacciati di opportunismo e di gestione inefficiente.
Tale conclusione trova anche conforto sul fatto che il ricorso al MES od ai Coronabond non garantiscono il ristoro economico che molti attori istituzionali sono convinti di intravedere, in quanto, siamo sempre in presenza di forme di accensione di nuovi debiti per i singoli Stati Membri che ne facessero uso. In pratica, il MES ed i Coronabond coincidono nella sostanza.
Infatti, l’accesso al MES comporta per lo Stato Membro beneficiario l’accensione di nuovo debito, anche in se in forma minimamente condizionata ed a costi bassissimi, da restituire obbligatoriamente, poiché il MES si connota come un fondo assicurativo con quote garantite da tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.
Invece, i Coronabond non sarebbero altro che un debito garantito da tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, anche quindi, dall’Italia. In pratica, il meccanismo è il medesimo. In primo luogo, gli Stati Membri dell’Unione Europea costituirebbero una cassa comune per le risorse necessarie. In seguito, la Commissione Europea (o lo stesso MES) utilizzerebbe questa cassa comune per emettere debito a condizioni molto vantaggiose, giovandosi della credibilità della cassa medesima come garanzia, per, poi, prestare risorse ai singoli Stati Membri a condizioni più vantaggiose di quelle che ciascun Paese potrebbe singolarmente ottenere sul mercato.

La riapertura.
In ultimo, non bisogna sottovalutare l’importanza strategica di una corretta programmazione della riapertura delle attività produttive.
Le decisioni che dovranno essere prese in tal senso sono sicuramente complesse e colme di incertezze. Inoltre, dovranno essere adottate alcune precauzioni, che consentano alle imprese ed ai lavoratori di arrivare preparati a quest’appuntamento.
Innanzi tutto, bisogna chiarire che è errato pensare alla c.d. “fase 2” come un momento di cesura netta tra la fase dell’emergenza sanitaria e quella della riapertura. Infatti, il processo di riapertura delle attività produttive sarà lento e con una gradualità irregolare, durante il quale soltanto la tempestività nell’individuazione e nell’isolamento di eventuali nuovi casi consentirà di andare avanti.
In secondo luogo, le informazioni relative all’effettiva diffusione dell’epidemia sono ancora troppo poco circostanziate ed eterogenee da regione a regione. A fronte di tali incertezze, risulta oltremodo difficile assumere decisioni sulla riapertura delle attività.
Appare evidente che, senza un monitoraggio costante dei tamponi su segmenti della popolazione, sarà impossibile seguire la dinamica del contagio, che, lo ribadiamo, sarà ancora in atto per i prossimi mesi a venire.
Ovviamente tale monitoraggio deve garantire in primis le fette di popolazione più a rischio, come, ad esempio i lavoratori che non potranno lavorare in modalità agile.
In tale contesto operativo, sarà necessario conoscere quale sia stata l’evoluzione del contagio per individuare, tramite campionamenti mirati, coloro che sono stati contagiati e sono guariti senza o con pochi sintomi.
Si tratta di un’operazione difficile e costosa, ma necessaria fino a quando non sarà disponibile un vaccino, al fine di concedere un minimo di agibilità nella vita delle persone.
Infine, la riapertura necessiterà l’adozione di un piano dettagliato, settore per settore, se non, addirittura, impresa per impresa, che preveda specifici protocolli di sicurezza per i lavoratori.
Tale piano dettagliato è necessario per non subire una nuova ondata di ricoverati in terapia intensiva a seguito della riapertura delle attività produttive, in quanto se le grandi imprese del settore manifatturiero sembrano essere meglio attrezzate ed, in parte, già pronte a gestire tale situazione, nelle piccole imprese e nelle attività informali si annida il rischio di un nuovo contagio.
In tal senso, il recente accordo tra FCA ed i sindacati confederali rappresenta un primo rassicurante esempio di piano capace di disciplinare la ripresa delle attività in un’impresa di grandi dimensioni, in quanto in esso si prevede che l’informazione sostanziale rivolta ai lavoratori deve prevalere sull’aspetto della loro formazione formale.
Tuttavia, permane il forte dubbio di quante piccole e medie imprese siano in grado di replicarlo. Sarà, quindi, necessario attivare subito presso tutte le imprese una capillare formazione dei lavoratori per la sicurezza al Covid-19, poiché è chiaramente insufficiente limitarsi ad aggiornare il DVR (documento valutazione dei rischi).
Ovviamente, tutte queste azioni dovranno essere accompagnate da un costante monitoraggio, al fine di evitare abusi e omissioni, rispetto ai quali l’attività degli organi di vigilanza non sarà sufficiente, ma sarà necessario anche l’impegno di tutte le parti sociali presenti in azienda e sul territorio, per non farsi trovare nuovamente impreparati.
BlogNomos
Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/blognomos
e su Twitter: @BlogNomos