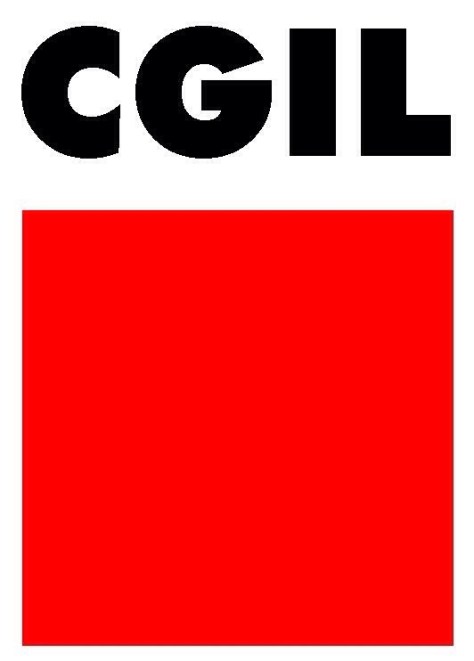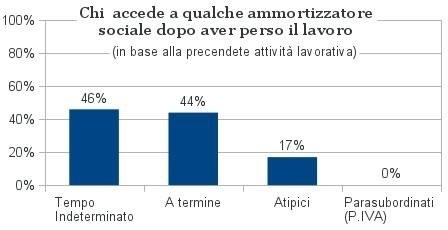di Michele De Sanctis
Dal 2008 ad oggi, tutto ciò che è apparso come qualcosa di nuovo, fin dal default degli Usa, è, in realtà, la riproposizione di quanto accade dal 1971. Dall’abbandono da parte degli Stati Uniti degli accordi di Bretton Woods, per l’esattezza. Durante la conferenza di Bretton Woods del ’44, infatti, erano stati presi degli accordi che avevano dato vita ad un sistema di regole e procedure volte a regolare la politica monetaria internazionale con l’obiettivo di governare i futuri rapporti economici e finanziari, impedendo di ritornare alla situazione che diede vita al secondo conflitto mondiale. La decisione si rese necessaria poiché tra le cause del secondo conflitto mondiale andavano, altresì, annoverate le diffuse pratiche protezionistiche portate avanti dai singoli Stati, le svalutazioni dei tassi di cambio per ragioni competitive e la scarsa collaborazione tra i Paesi in materia di politica monetaria. I due principali compiti della conferenza furono, perciò, la creazione di condizioni idonee ad una stabilizzazione dei tassi di cambio rispetto al dollaro (eletto a valuta principale) e la eliminazione di quelle condizioni di squilibrio determinate dai pagamenti internazionali (tale compito fu affidato al FMI). Secondo il sistema definito da Bretton Woods il dollaro era l’unica valuta convertibile in oro in base al cambio di 35 dollari contro un oncia del metallo prezioso. Il dollaro venne così eletto valuta di riferimento per gli scambi, mentre alle altre valute furono consentite solo oscillazioni limitate entro un regime di cambi fissi a parità centrale. Per raggiungere l’obiettivo di vigilare sulle nuove regole e sul sistema dei pagamenti internazionali furono creati il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), due importanti istituzioni esistenti ancora oggi, che diventarono operative nel 1946. Inizialmente il numero di Paesi aderenti al FMI era ridotto: per aderire ogni Stato doveva versare una quota in oro e una in valuta nazionale sulla base delle quali veniva deciso il proprio peso decisionale. L’obiettivo del Fondo era quello controllare la liquidità internazionale e coadiuvare i vari Paesi nel caso di difficoltà nella bilancia dei pagamenti.
Tuttavia, la guerra del Vietnam, il forte aumento della spesa pubblica e del debito americano segnarono la fine i questo sistema.
Infatti, il 15 agosto 1971 a Camp David Richard Nixon sospese la convertibilità del dollaro in oro, in quanto, con le crescenti richieste di conversione in oro le riserve americane si stavano sempre più assottigliando. Successivamente, il dicembre di quello stesso anno segnò il definitivo abbandono degli accordi di Bretton Woods da parte dei membri del G10 (il gruppo dei dieci Paesi formato da Germania, Belgio, Canada, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia). Con lo Smithsonian Agreement il dollaro venne svalutato e si diede il via alla fluttuazione dei cambi.
Nondimeno, le istituzioni create a Bretton Woods sopravvissero ma si trovarono a ridefinire priorità e obiettivi. In particolare, il FMI, con la caduta di Bretton Woods, vide di fatto cambiare il proprio ruolo di sorveglianza. Con l’introduzione dei cambi flessibili e l’abbandono dello standard aureo, venne meno la necessità di gestire la liquidità internazionale e l’attenzione del FMI fu piuttosto portata sulle politiche macroeconomiche interne perseguite dai membri e sugli elementi strutturali dei loro mercati. Venne poi data priorità all’obiettivo di finanziamento degli squilibri della bilancia dei pagamenti dei Paesi in via di sviluppo trasformando il FMI da prestatore a breve termine a prestatore a lungo termine. Pertanto, il FMI si trovò investito del compito di effettuare prestiti vincolati al rispetto di specifiche condizioni e a piani di rigorosa stabilizzazione macroeconomica. Una funzione che il FMI mantiene ancora oggi, come dimostrano i recenti sviluppi collegati alla crisi dell’Euro e ai piani di salvataggio di Grecia, Irlanda e Portogallo, che vedono il Fondo quale prestatore di prima istanza insieme all’UE.
Con la fine degli accordi di Bretton Woods, dunque, gli USA hanno deciso, in base al loro potere politico e militare, di imporre il proprio indebitamento come peculiare modello di sviluppo, il cui costo, però, veniva fatto pagare agli altri. Debito privato, debito pubblico e consumo sostenuti dal mix tra debito interno ed esterno, tuttavia con dei fondamentali macroeconomici alquanto deboli: l’economia reale, già allora, mostrava, infatti, i caratteri della crisi strutturale e sistemica.
È da questo momento in poi che può analizzarsi la genesi dell’attuale crisi, che altro non è che un sintomo di esaurimento messo in moto dal capitale americano in quegli anni per continuare ad attrarre manodopera a basso costo privata, tra l’altro, della garanzia dei diritti sindacali minimi, oltreché risorse materiali dal resto del mondo in forma di merci. Sempre a credito.

Lo scenario economico internazionale, peraltro, acuisce le proprie criticità sistemiche all’indomani della caduta del muro di Berlino e il successivo crollo dell’Unione Sovietica, quando si apre una fase di guida unipolare del mondo basata sullo strapotere politico e militare degli Stati Uniti, che, imponendo l’acquisto dei loro titoli hanno altresì imposto il sostegno della loro crescita basata su indebitamento ed economia di guerra. Successivamente, nel corso degli anni ’90 si aprì una fase di competizione globale, basata non tanto e non solo sul modello importatore degli americani, quanto segnata dai tentativi dell’Europa di trovare i suoi spazi di affermazione economica, puntando a un ruolo internazionale, con una forte posizione di esportatore svolto dalla Germania. Nel contempo, lo stesso modello di economia basata sulle esportazioni viene realizzato dalla Cina, che, grazie ai suoi avanzi nella bilancia dei pagamenti, decide di diventare il maggior compratore del debito statunitense. Il modello tirava e fu così che le banche tedesche e lo Stato cinese iniziarono ad acquistare titoli USA e, in parte, anche di altri Stati membri dell’UE. Questi ultimi, d’altro canto, dovevano subire lo strapotere tedesco e con questo la costruzione dell’Unione Europea come nuovo polo imperialista che, pur mancando di grande forza interna politica e militare, imponeva una logica economico-finanziaria tedesca.
Ma, come è ovvio, un sistema basato sull’indebitamento non può reggere all’infinito. Capita sempre che, a un certo punto, qualcuno presenti il conto!
Siamo a cavallo del 2007-2008. Negli USA scoppia la crisi dei subprime: il crack viene subito evidenziato come crisi finanziaria dovuto allo scoppio delle bolle speculative immobiliari e finanziarie, ma è solo la punta dell’iceberg. In realtà, più che finanziaria è una crisi dell’economia reale, dei meccanismi stessi dell’accumulazione: erano, cioè, gli stessi meccanismi del modo di produzione capitalistico che si erano ‘inceppati’ già nei primi anni ’70 e che nel 2008 dimostravano quanto quella crisi fosse divenuta ineluttabile, irreversibile e di carattere sistemico. Le privatizzazioni, l’attacco indiscriminato al costo del lavoro, al sistema del welfare e ai diritti, ma soprattutto la finanziarizzazione dell’economia finora hanno soltanto cercato di coprire una crisi dell’economia reale che si porta dietro il carattere della strutturalità e della sistemicità.
La competizione globale si inasprisce, così come pure il tentativo di centralizzare la ricchezza in poche mani, tentativo, peraltro, accompagnato da sempre più frequenti ‘guerre’: economico-finanziaria, commerciale e sociale. E infine da guerre militari per accaparrarsi nuove risorse. La caduta del regime di Gheddafi, per esempio, non è stata solo esportazione di democrazia, ma prima ancora è stata una conquista di matrice imperialista.
Contemporaneamente, la finanziarizzazione allargava il proprio giro, segnando l’arrivo dei Paesi che prima venivano denominati paesi in via di sviluppo, che ora divengono emergenti: i cosiddetti BRICS.
Sul fronte UE, invece, il modello esportatore tedesco, che aveva ormai sempre più bisogno di importatori, anche direttamente europei, porta la Germania ad investire l’avanzo che matura comprando titoli dei PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna). A loro volta, questi Paesi sono costretti ad indebitarsi per rispondere alle regole dell’euro, soffocando le proprie economie e massacrando il mondo del lavoro per garantire che la “questione” dell’Euro rimanga funzionale allo sviluppo esportatore della Germania (e in seconda battuta agli interessi francesi). Gli stessi Stati Uniti hanno un indebitamento in parte sostenuto dalla Germania oltre che dalla Cina. La competizione, però, oggi è ancora più aspra, come si è già accennato, perché ci sono nuovi competitor e i BRICS rivendicano il loro spazio.
A questo punto gli USA che non hanno più la forza politica e militare per imporre al mondo il proprio modello di sviluppo fondato sul loro indebitamento, si vedono costretti a chiedere l’innalzamento del debito appunto perché sanno che fuori dai loro confini non troverebbero poi tanti soggetti disposti a finanziare il Paese come avveniva nella vigenza del precedente modello economico. E questa è la prova che il mondo a guida unipolare basato sull’egemonia statunitense è ormai tramontato.
Quello di spostare il problema del debito più avanti, cioè di tentare di far fronte al deficit, che è un dato congiunturale di flusso, trasformandolo in esposizione strutturale di stock, è un problema non solo americano, ma anche italiano. L’Italia sembra, infatti, entrata in una spirale perversa tra recessione e maggiori interessi sulla vendita dei titoli che dovrebbero servire a finanziare il debito (sic!). Il dato preoccupante, però, è che un esposizione strutturale di stock oggi sarà debito sovrano domani. Cioè il debito che penderà sulle future generazioni di lavoratori. E i meccanismi per far fronte al deficit, certe manovre ‘lacrime e sangue’ che ci vengono imposte per la prima volta, diventeranno la norma. Perché fintantoché si continuerà a far cassa a discapito dei lavoratori ogni manovra sarà lacrime e sangue. Ma se il debito continuerà ad essere finanziato con altro debito, con la vendita, cioè, di altri titoli, il circolo vizioso che s’è creato potrà spezzarsi con molta difficoltà. Perché diventerà il sistema. La parte di deficit che si capitalizza, quindi, è una mannaia per le generazioni del futuro.

Ho parlato di spirale perversa, di circolo vizioso, ma, in realtà, il meccanismo descritto altro non è che semplice speculazione finanziaria. Eppure, all’indomani del crollo dei subprime americani ad essere messi sotto accusa non era stata proprio la finanza speculativa? La risposta è ovvia quanto evidente. Il mercato non conosce sazietà. “Guasto e’ il mondo, preda di mali che si susseguono, dove la ricchezza si accumula mentre gli uomini vanno in rovina” recita la tomba del poeta inglese Oliver Goldsmith.
Guasto è il mondo, diceva Tony Judt nel testo che ha lasciato in eredità al l’umanità. Guasto perché il mercato è lasciato a se stesso, senza controlli o con meno controlli, perché il mercato che ha divorato se stesso ha ancor più necessità d’essere alimentato. Guasto perché gli appetiti personali sono diventati di colpo coraggiose virtù, la diseguaglianza s’è diffusa; la finanza, non più il lavoro e la produzione, è diventata la risorsa prima dell’economia. Guasto perché alla fine è arrivato il conto da pagare, salatissimo.
Il problema che si pone non è quello della crisi finanziaria ma di una crisi del modello di accumulazione: in crisi è quindi l’intero sistema capitalista. La finanza speculativa, che doveva essere quella in crisi, si sta, invece, riaffacciando in modo prepotente sfoderando armi diverse e combattendo su nuovi terreni. La speculazione finanziaria è ancora lì, come un avvoltoio, con quegli strumenti creativi con cui aggredisce chi non accetta le regole di dominio e che non effettua attacchi sempre più pesanti contro il salario diretto, indiretto e differito.
Sotto l’effetto di interessi particolari ed appetiti economici Gli ideali e la volontà di costruire una società coesa, prevalenti in Occidente nel dopoguerra, sono stati colpevolmente lasciati cadere. Per qualche decennio, hanno fatto da guida gli ideali keynesiani di un mercato temperato dall’intervento dello Stato. Le migliori leggi e le migliori politiche sociali adottate dall’America nel corso del XX secolo corrispondono in gran parte a ciò che gli europei chiamano socialdemocrazia. Ma poi qualcosa si è rotto: “Dovunque ti girassi” scrive Judt, “trovavi un economista o un ‘esperto’ che decantava le virtù della deregolamentazione, dello Stato minimo e delle tasse basse”. L’abbiamo sentita cantare anche noi questa canzone e ne stiamo sopportando i risultati.
Per uscire dal debito greco, per esempio, si stanno approntando nuovi strumenti di finanza creativa che dilazionano l’indebitamento e creano le premesse di nuovi collassi. La finanzia continua a svolgere il suo ruolo speculativo, in questo gioco al massacro ai danni delle casse pubbliche, dei salari e dello Stato sociale.
Il problema non è dunque la crisi finanziaria scoppiata nel 2008 ma il fatto – piuttosto – che per trent’anni abbiamo trasformato in virtù il perseguimento dell’interesse materiale personale, anzi, ormai questo è diventato l’unico scopo collettivo che ancora ci rimane.
In questo modo di fare, anzi di vivere, lo Stato è diventato un problema non una soluzione; le disuguaglianze sociali aumentano perché tutto si incentra sulla capacità e sulla furbizia di ciascun individuo, mentre i redditi tendono a concentrarsi nella cuspide della piramide in quanto lo sviluppo “sociale” del dopoguerra diventa “personale” per essere definitivamente abbandonato.
Il problema, pertanto, non è solo economico, ma altresì etico e politico. Secondo Hessel, le società civili, i giovani, in particolare, hanno il dovere morale di reagire di fronte a questa situazione. Di indignarsi! Secondo Judt, poi, avere idee nuove, per una società nuova, intendo, è fondamentale, in quanto è da qui che si parte per nuove correnti di pensiero, correnti che un giorno, magari, si trasformeranno in vere e proprie leggi.
Se la società è scomparsa a favore degli individui e se tutto ma proprio tutto verte sull’economia, ciò che riguarda l’etica – che implicitamente significa eguaglianza – diventa ogni giorno di più una cosa risibile. Ma questa cosa risibile è proprio il nostro punto da cui ripartire per riformare l’intera società. Oggi rivoluzione significa che dobbiamo tendere alla formazione di una “società nuova”. Bisogna, infatti, coniugare l’efficienza del capitalismo con la società, riducendo gli squilibri e permettendo allo Stato di rimanere un attore fondamentale all’interno del sistema sociale e del mercato.

La politica, dunque, è la strada maestra, l’unica via percorribile affinché si possano regolamentare difendere i cittadini più deboli e vessati da questo sistema, cittadini che ogni giorno aumentano sempre di più. È, pertanto, indispensabile l’impegno politico e sociale di tutti i cittadini, che devono continuamente spronare e stimolare il dibattito pubblico, al fine di evitare che si spenga tra le ceneri del potere.
Se infatti ci si arrendesse, il gioco al massacro a cui stiamo assistendo continuerà finché il numero delle vittime non sarà superiore a quello dei salvati. E accadrà davvero se non ci riappropriamo di un’etica della politica e se, nel contempo, non smettiamo di pensarci come singoli individui, piuttosto che come membri di un’unica società.
Dal punto di vista pratico, per mettere un argine a questa situazione, per lo meno nel vecchio continente, bisogna innanzitutto abbandonare la via tracciata dalla Trojka. Infatti, la cosa assurda è che chi dovrebbe confezionare proposte in grado di tirarci fuori da questa situazione in realtà pensa agli interessi di una sola parte dei Paese di Eurolandia, i ricchi e i soliti noti, banchieri e finanzieri, come dimostrano le ultime leggi finanziarie e la legge di stabilità. Secondo Luciano Vasapollo, docente di Economia applicata a La Sapienza, una prima risposta può essere lanciare una campagna del mondo del lavoro non contro l’Europa, ma contro le regole del massacro sociale imposte dalle compatibilità economico-finanziarie dell’euro. La seconda questione che va posta all’ordine del giorno è rilanciare una serie di politiche in ordine ad un’efficiente nazionalizzazione e statalizzazione delle banche e dei settori strategici dell’economia. Il debito sovrano sta diventando un nodo nei Paesi deboli, perché con i soldi pubblici si sono finanziate le banche. Quindi la prima nazionalizzazione deve essere del sistema bancario. E poi è necessario porre immediatamente la soluzione del nodo dei settori strategici di energia, trasporti e comunicazioni che devono da subito ritornare in mano allo Stato. Quello che Vasapollo prospetta nel suo illuminante saggio del 2011 ‘Il risveglio dei maiali. PIIGS. Le proposte di CESTES-PROTEO’ sembrerebbe un ritorno agli anni 50-60, quando si creò in Italia una forte economia mista, con un welfare vero e un futuro per i giovani.
Tuttavia, le tesi di Vasapollo sono in linea con quelle di altri economisti critici ed eterodossi, che, nelle loro varie componenti, stanno cercando di trovare un accordo su un programma minimo di controtendenza da proporre e insieme praticare con il ruolo centrale del sindacalismo conflittuale di classe. In ogni caso, se da un punto di vista logico, esistono, infatti, varie alternative possibili alla attuale competizione globale, fino alla maggiore determinazione del superamento del modo di produzione capitalista, d’altro canto ognuna presenta distinti gradi di probabilità in funzione di ragioni tecnico-economiche o politico-sociali. Ciò che più rileva, comunque, è che qualsiasi proposta attuabile dovrà “fare i conti”, in primo luogo, con la tecnologia. Il cambio tecnologico può rappresentare un progresso tecnico e sociale solo se è frutto di una decisione collettiva dei lavoratori, maggioritaria, responsabile, aperta al dialogo, negoziata e contrattata. Dall’epoca “luddista” – l’epoca di quegli operai che distruggevano le macchine che andavano ormai a prendere il loro posto nelle fabbriche tessili -, i sindacati dei lavoratori hanno rinunciato a controllare, a regolare e a partecipare nel senso e nell’orientamento del cambio tecnico. È stata una decisione che si è lasciata sempre in mano agli imprenditori e al capitale. Invertire questa tendenza secolare implica intendere in altra maniera lo sviluppo democratico, comprendere che il dibattito sulla tecnologia, che è in fondo parte del dibattito tra marxisti, esige che tra i lavoratori vi sia una cultura tecnologica – che oggi non c’è -, delle strutture che servano a canalizzare e organizzare il dibattito sul cambio tecnico. L’attuale processo di privatizzazione delle risorse, per esempio, verrebbe superato proprio da questa nuova cultura tecnologica. In secondo luogo, anche l’economista Vasapollo dichiara la necessità etica di un cambiamento radicale di tipo socioculturale (quello che in termini gramsciani si chiama un cambio di egemonia che modifichi il senso comune): un cambio che inverta le relazioni causali tra l’economia e la politica. La politica, infatti, è sempre stata al servizio dell’economia, quantomeno dal XIX secolo. Il discorso politico occultava precedentemente questi interessi nell’essenza dell’economia; ma nel XX secolo c’è stata una svolta, il discorso politico è stato colonizzato dagli interessi economici, tanto che oggi sembra che parlare di politica sia esclusivamente parlare di economia, di spesa pubblica, di interessi, di imposte, di marche legali, di legislazione del lavoro o legislazione commerciale. Questo è logico solamente in un sistema che subordina lo sviluppo sociale agli interessi di mercato.

Le proposte concrete e immediate sono quindi quelle offerte da nazionalizzazioni, investimenti in edilizia pubblica, lavoro e salario pieno e a totalità di diritti veri, di uscita dall’euro (o quantomeno di creazione di un euro debole nell’area mediterranea e in Irlanda), ma più importante di tutte è la proposta di azzeramento del debito. Questi sono i primi punti qualificanti il programma minimo di controtendenza.
Il problema è che l’economia finanziaria non crea risorse perché sul medio periodo è un gioco a somma zero, quindi in questo ballo mascherato delle celebrità , cioè dei potentati finanziari devono entrarci gli Stati, i lavoratori, in ultima istanza, su cui si scarica tutta la durezza e drammaticità della crisi. Per esempio, in Grecia non bisogna dilazionare ma dare un taglio netto. E del resto è quanto è già stato fatto in Sud America, ad esempio quando l’Argentina girò le spalle al Fondo Monetario Internazionale. Se si entra nella logica della diminuzione del tasso di interesse e di allungamento del debito, il ricatto diventa continuo e l’economia reale perde completamente i parametri di sostenibilità sociale e ambientale. Per questo, un’alternativa globale ridefinisce il discorso politico nel terreno del sociale e subordina, a questo discorso politico sul sociale, il discorso economico e il discorso politico sull’economia. L’Europa deve costruire in maniera indipendente le proprie prospettive muovendosi da subito in piena autonomia da qualsiasi modello consociativo, concertativo e di cogestione della crisi. Solo così l’autonomia di classe potrà assumere un vero connotato di indipendenza dai diversi modelli di sviluppo voluti e imposti dalle varie forme di capitalismo, ma soprattutto da quel sistema di sfruttamento imposto dall’unico modo di produzione che il capitale sia stato in grado di conoscere. E in tal senso il movimento dei lavoratori non può e non deve essere elemento cogestore della crisi, ma nella crisi deve trovare gli elementi del rafforzamento della sua soggettività politica. Ciò vuol dire che non è accettabile alcuna gestione della crisi da parte dei lavoratori, né è ammissibile un nuovo sistema compatibile con la sopravvivenza del capitalismo: l’indipendenza del mondo del lavoro dal cosiddetto ‘sviluppismo’ capitalista significa in primis non collaborare ma offrire un proprio programma minimo di classe al di là delle compatibilità del capitale, esprimendo, così, tutta la propria autonomia nella conflittualità. Entrare nel gioco significherebbe piuttosto morire nel gioco! Sono sempre i più deboli che soccombono: prosperano, cioè, i fondi pensione e di investimento e perdono i lavoratori con la privazione di pensioni e salari, del welfare e dei diritti sociali.

Subordinare l’economia alla politica sarebbe quindi un’alternativa alla mondializzazione capitalista realmente esistente. Non è, in fondo, altra cosa del vecchio, ma non antico né superato, programma delle organizzazioni internazionali di classe: la subordinazione del capitale al lavoro, della produzione all’essere umano.
BlogNomos