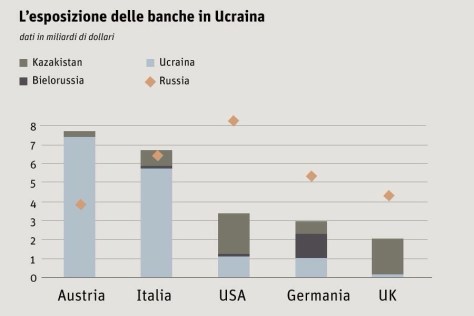Il 14 febbraio 1984 venne siglato l’ormai famoso accordo, entrato nella storia sindacale italiana, come l’“Accordo di San Valentino”. Tale intesa, sottoscritta con il governo Craxi soltanto da UIL e CISL, comportò la decisione di tagliare di quattro punti percentuali la scala mobile e creò una spaccatura sindacale con la CGIL, allora guidata dal Segretario Luciano Lama, la quale non firmò l’intesa. Fu la fine della federazione sindacale unitaria.
La medesima CGIL non resse alle tensioni provocate dalla mancata sottoscrizione dell’accordo, al punto che si realizzò una grave frattura tra sua maggioranza comunista e la sua componente minoritaria socialista, capitanata Ottaviano Del Turco.
Le frizioni prodotte dall’accordo furono anche politiche, in quanto l’allora segretario del PCI, Enrico Berlinguer, si oppose duramente ad esso.
Il contenuto dell’accordo divenne il testo di un apposito decreto legge approvato dal Governo Craxi, che venne, poi, convertito nella Legge 12 giugno 1984 n. 219. Siffatto provvedimento legislativo si connotò, appunto, per l’espressa previsione di un taglio di 4 punti percentuali della scala mobile.
Il 9 e 10 giugno 1985 si svolse un referendum abrogativo sulla scala mobile, promosso dal solo PCI. L’esito referendario fu negativo. A fronte, di un’affluenza alle urne del 77,9%, il 45,7% dei votanti si espresse a favore dell’abrogazione della norma, mentre il 54,3% si oppose. Di conseguenza, il taglio rimase.
Con l’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, si avviò la pratica concertativa, che portò alla definitiva abrogazione della scala mobile con la firma del protocollo triangolare di intesa tra il Governo Amato I e le parti sociali avvenuta il 31 luglio 1992. Con la scala mobile, è stata abolita l’indennità di contingenza ed è stato introdotto per tutti i lavoratori dipendenti (dirigenti esclusi) l’elemento distinto della retribuzione. In seguito, l’altrettanto storico “Accordo del luglio 1993”, corresponsabilizzò le parti sociali ed il Governo, allora presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, nel controllo dell’inflazione e della spesa pubblica. Quest’ultimo accordo ampliò gli spazi della contrattazione salariale, proprio come diretta conseguenza dell’eliminazione della scala mobile. Per tale ragione, l’Accordo del luglio 1993 assunse la concertazione come unico metodo regolatore delle dinamiche tra le parti sociali.
Venendo al contenuto dell’Accordo di San Valentino, esso aveva come oggetto l’adozione del meccanismo proposto da Ezio Tarantelli che comportava la rideterminazione dei punti di scala mobile per favorire la discesa dell’inflazione.
Si trattava dell’esito sofferto di un lungo negoziato, in virtù del quale il Governo s’impegnava a garantire il blocco dei prezzi e delle tariffe per due mesi, la sospensione degli scatti dell’equo canone per tutto l’anno 1984 e la restituzione del fiscal drag dall’anno successivo. A fronte di ciò, il Governo richiedeva l’accettazione da parte delle parti sociali del taglio di alcuni punti di scala mobile. Pertanto, a seguito dell’Accordo di San Valentino, scomparve il meccanismo d’indicizzazione delle retribuzioni, previsto dalla scala mobile.
L’istituto della scala mobile, sin dal 1951, aveva protetto il potere d’acquisto dei salari, adeguando automaticamente la dinamica salariale a quella inflazionistica sulla base di aumenti, in quanto, a fronte delle variazioni dell’indice dei prezzi, scattavano corrispondenti aumenti delle retribuzioni. Il punto di contingenza era uguale per l’intero Paese e per tutti i comparti dell’economia nazionale, ma con valori diversi a seconda della categoria, della qualifica, dell’età e del genere.
Tale sistema venne fortemente rafforzato dopo il 1975, in quanto, attraverso uno specifico accordo confederale, si stabilì l’unificazione del valore nominale del punto di contingenza (a punto unico e pesante, implicando così variazioni percentuali molto più forti per le retribuzioni più basse). Tale unificazione era la diretta conseguenza della politica sindacale mirante all’egualitarismo salariale, politica che, perseguita agli inizi degli anni ‘70 del secolo scorso e favorita anche dalla spinta inflazionistica che rendeva l’indennità l’elemento preponderante dell’intero incremento retributivo. La più immediata conseguenza di tale decisione fu l’appiattimento dei salari. Nel 1975, l’ambito di applicazione della scala mobile era limitato al solo settore bancario. In seguito, la scala mobile venne estesa anche agli altri settori con un accordo stipulato tra la Confindustria e CGIL, CISL e UIL, le tre maggiori organizzazioni sindacali.
In virtù di tale accordo, la scala mobile (denominata ufficialmente “indennità di contingenza”) si trasformò in un autentico uno strumento economico di politica dei salari, volto ad indicizzare automaticamente i salari all’inflazione ed all’aumento del costo della vita secondo un indice dei prezzi al consumo. Essa era calcolata, seguendo l’andamento variabile dei prezzi di particolari beni di consumo, generalmente di larga diffusione, costituenti un paniere. Una commissione ad hoc svolgeva il compito di determinare ogni tre mesi le variazioni del costo della vita utilizzando come indice di riferimento le variazioni dei prezzi di tali beni (indice dei prezzi al consumo, IPC). Una volta accertata e resa uguale su base 100 la somma mensile necessaria per la famiglia-tipo, in riferimento ad un dato periodo per l’acquisto dei prodotti del paniere, le successive variazioni percentuali dei prezzi dei beni di consumo divenivano i punti di variazione dell’indice stesso del costo della vita, a cui i salari venivano direttamente adeguati.
Successivamente, il meccanismo venne aspramente criticato per le implicazioni fortemente lesive dei valori della professionalità, in particolare, delle categorie medio-alte, nonché per l’automatico generarsi di una spirale prezzi-salari. Di conseguenza, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, venne avviato un graduale processo di riforma della scala mobile.
Inizialmente, intervenne il così detto “Protocollo Scotti” del 22 gennaio 1983, il quale adottò alcune misure di contenimento del meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni, stabilendo un nuovo valore del punto di contingenza. Come sopra visto, il persistente incremento del costo del lavoro rispetto al tasso d’inflazione programmato spinse poi, nel 1984, il governo guidato da Bettino Craxi del PSI ad operare un ulteriore contenimento del meccanismo, disponendo la predeterminazione dei punti di contingenza da corrispondere e limitandola ai primi due trimestri.
Infine, lo ricordiamo, dal 1992, la scala mobile è cessata e, da allora, viene pagata solo l’indennità di contingenza maturata fino ad allora. In molti contratti collettivi, essa è stata conglobata nella paga base. L’accordo sul costo del lavoro del luglio 1993 ha affidato alla contrattazione nazionale per le singole categorie la determinazione della rivalutazione automatica delle retribuzioni, disponendo l’indennità di vacanza contrattuale.
A distanza di trent’anni dall’Accordo di San Valentino, il quadro economico e sociale è profondamente mutato.
L’economia italiana è, ormai, prossima alla deflazione, mentre, allora, il tasso di crescita del costo della vita si manteneva stabilmente su due cifre percentuali. Oggi, la disoccupazione ha raggiunto livelli altissimi, mentre, allora trovare lavoro non era tanto difficile, in quanto il “Sistema Paese” era ancora in piena fase di crescita, avendo un prodotto interno lordo nettamente positivo ed un il livello dei consumi costantemente in rialzo. Inoltre, il debito pubblico era ancora sotto controllo e la Commissione Europea non aveva ancora strumenti di controllo così invasivi, anche perché la moneta unica era soltanto un’idea utopica.
In altri termini, l’Accordo di San Valentino operò i suoi effetti su un Italia completamente diversa da quella attuale. Probabilmente, l’unico elemento comune tra le due epoche è rinvenibile nella divisione della sinistra, unitamente alla crisi del sindacato unitario ed la CGIL spaccata.
Tuttavia, se si analizza bene quel lontano e così diverso quadro macroeconomico, è possibile rinvenire l’origine di molti dei mali che affliggono attualmente l’Italia.
Nel corso degli anni ‘80 del secolo scorso, cominciò la crisi del nostro modello di sviluppo, prima in forma lieve ed episodica, per, poi, divenire sempre più marcata e sistemica.
La ricerca di un facile consenso elettorale comportò l’aumento esponenziale ed incontrollato del debito pubblico.
Infine, le crisi petrolifere di quegli anni anticiparono le prime controindicazioni di un economia mondiale che andava progressivamente globalizzandosi.
Purtroppo, la politica, l’imprenditoria ed i sindacati non colsero il vero significato di queste avvisaglie negative, essendo unicamente concentrati sulla sterile discussione avente ad oggetto il taglio di qualche punto percentuale di contingenza. Anzi, negli anni a seguire, le istituzioni e le parti sociali non sono state capaci d’interpretare le nuove istanze generate dall’economia globale, con la conseguenza che non sono riuscite ad elaborare per il nostro Paese alcun nuovo modello di sviluppo condiviso, capace di contrastare il declino del sistema economico e sociale nazionale.
L’esame di quel periodo storico ci porta all’amara constatazione che gran parte dei temi economici sottesi a quell’accordo sono tuttora di estrema attualità. In altri termini, nonostante i mille stravolgimenti subiti dall’Italia negli ultimi trent’anni, il nostro sistema economico e sociale è rimasto praticamente immobile.
Siamo di fronte a decenni di mancata crescita. Il male dell’Italia sono l’immobilismo e le riforme mancate. Servono le riforme strutturali, capaci di voltare pagina con le politiche economiche ed industriali del passato, anche perché l’ormai mitizzata crescita degli anni ‘70 ed ’80 del secolo scorso era drogata dalla svalutazione e dall’aumento del debito pubblico. Si tratta di scelte sistemiche non più spendibili, non soltanto per i vincoli imposti da una moneta unica forte e dalla recente previsione costituzionale della parità di bilancio, ma specialmente perché il mercato globale ha permesso l’arrivo di nuovi Paesi capaci di offrire costi di produzione talmente bassi da rendere quelle politiche passate totalmente inutili.
Bisogna capire che senza crescita non c’è benessere e la crescita è ottenibile puntando sul mercato, sul merito e sulla legalità, ma, soprattutto, sulla ricerca e sull’innovazione. Soltanto producendo prodotti innovativi ad elevato contenuto tecnologico, l’Italia potrà tornare ad essere un Paese produttore competitivo ed in grado di garantire, sia una crescita adeguata alla sua economia, che salari adeguati ai propri lavoratori.
Invece, attualmente, l’Italia è un paese bloccato, che non cresce e che impone vincoli soffocanti alla capacità d’impresa e, di conseguenza, all’innovazione ed al benessere.
Le cause di quest’immobilismo sono molteplici. Basti pensare alla permanenza di un sistema economico ancora fortemente corporativo ed oligopolista, ad una Pubblica amministrazione inefficiente, ad un sistema fiscale esoso sui redditi da lavoro dipendente e sui costi d’impresa, che drena eccessivamente risorse, senza combattere adeguatamente la sua evasione. Tali inefficienze sono risolvibili soltanto con profonde, radicali e condivise riforme strutturali.
Tale stato di fatto spiega l’esistenza d’importanti settori dell’opinione pubblica, nei fatti, accanitamente contrari – anche, se a parole, favorevoli – a qualsiasi iniziativa industriale o di servizi, volta ad innovare profondamente l’utilizzazione del territorio.
Inoltre, nel dibattito contemporaneo ricorre frequentemente l’affermazione che il futuro dell’Italia è legato alla sua industria, mentre si riscontra una forte diffidenza nei confronti dei settori di produzione più moderni. L’Italia risulta sempre meno competitiva nel turismo, non si afferma nei servizi informatici, presenta una debolezza strutturale cronica nei trasporti e nelle comunicazioni. In un Paese che ritiene di avere uno spirito industriale, sovente, questi settori sono considerati distruttivi, o, quanto meno, disgreganti, rispetto all’ordine sociale, oltre che economico, consolidato. Inoltre, l’Italia sembra privilegiare l’industria per i motivi sbagliati, in quanto la ritiene portatrice di stabilità e non di mutamento. In altri termini, si ritiene che, privilegiando l’industria, si possa consolidare lo status quo, senza promuovere alcun cambiamento e perpetuando una tradizione sovente di origine preindustriale.
In altri termini, il sistema economico italiano si connota per le sue radici profondamente anti-innovative. Tale peculiarità paralizza qualsiasi decisione pubblica favorevole a un’innovazione di larga portata e che abbia, quindi, bisogno di una pubblica autorizzazione.
Tale tendenza è rafforzata anche dal fatto che spesso non vi è immediata rispondenza tra lo scopo finale dell’innovazione (spesso a lungo termine) e le sue immediate conseguenze. Infatti, negli ultimi trent’anni, si sono privilegiate le scelte a carattere contingente, a discapito delle riforme sistemiche, i cui benefici non sono immediatamente percepibili.
Lo stesso discorso può valere per le riforme legislative capaci d’incidere in maniera profonda su rapporti consolidati. Ogni qual volta il Parlamento ha approvato un testo di riforma, è subito apparso uno stuolo di oppositori che ha agitato le armi (qualche volta improprie) del ricorso alla Corte Costituzionale o del referendum abrogativo.
Germano De Sanctis